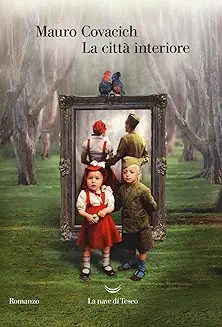Da Claudio Cherin riceviamo questa bella recensione.
Covacich, che ha dato sempre spazio alla sua città natale – non solo ambientando lì alcune sue storie ma ne descrive, con l’occhio del meteorologo, la bellezza della Bora, la sua superficie, i suoi profili taglienti, gli squarci di luce della città, nel libro Trieste sottosopra. Quindici passeggiate nella città del vento –, ritorna con La città interiore ancora una volta ripercorrere i vicoli di Trieste.
È l’orrore della Seconda Guerra Mondiale, la paura del Comunismo di Tito, l’avvento del Fascismo il passato della comunità slovena a cui è stata tolta la parola, quello con cui si confronta Mauro Covacich ne La città interiore. L’unico mezzo che gli permette di realizzare questa ardua impresa sono le parole degli altri e quelle proprie che permettono di far emergere la drammaticità degli eventi storici. Per questo, lo scrittore rincorre le voci che compongono la storia personale e collettiva di Trieste, città di frontiera e città segnata forse più di ogni altra dalla Storia Contemporanea.
La narrazione inizia con l’attentato terroristico del millenovecento settantadue, quando venne dato fuoco alle raffinerie petrolchimiche della città, e a cui l’autore, appena adolescente, assiste con il padre. Questo ricordo diventa il momento per riflettere sulla storia di Trieste, sulla sua ricchezza ma anche sulla sua ‘diversità’ intesa come una città ferita, che per molto tempo ha tenuto nell’ombra i suoi segreti. Chi ha amato il Quarantotti Gambini di Primavera a Trieste non potrà non considerare questo libro come ‘un luogo storico di riflessione’ di uno scrittore. Come Pier Antonio Quarantotti Gambini – che sul finire della guerra scrisse un diario collettivo in cui raccontava le illusioni, le paure, le speranze di una popolazione (quella di Trieste) che non sa cosa deve fare, quale sarà il suo destino – anche Covacich riflette sulla propria storia e sulla prepotenza storica che si abbatte da sempre sulla città ridivenuta italiana solo dopo la guerra.
Il solo modo che lo scrittore ha è quello di ‘farsi geologo’, raccogliendo le vite di artisti oggi dimenticati, parole, avvenimenti troppo presto scoparsi. Fa questo per comprendere il tragico passato prossimo della città del sogno asburgico.
Difficile dire che cosa sia questo libro: apparentemente è un libro di memorie familiari. Ma andando avanti nella lettura si capisce come sia riduttivo pensare a La città interiore, come un libro di memorie. Gli avvenimenti storici diventano un modo attraverso il quale lo scrittore si congeda dal padre morto. Covacich sa che la storia della propria famiglia coincide con la storia della città, con le illusioni e le speranze di chi ha combattuto e di chi aspetta che succeda qualcosa, per questo pur accennando ad episodi che vedono protagonista il padre, il suo racconto supera il memoir e diventa un luogo di riflessione storica. Dove la storia privata, la storia collettiva e l’identità di una città permettono allo scrittore di comprendere chi è.
Attraverso una scrittura schietta, lineare, spoglia, uno sguardo frammentario degli eventi, seguendo i canoni novecenteschi dell’impossibilità di sondare del tutto un evento storico o privato, lo scrittore triestino ha raggiunto una dimensione di «testimone mai affrancato dalle radici, dal destino di essere nato in una terra in cui i conflitti hanno aperto le porte alla grande cultura»., sostiene Sergio Penet.
Interrogando le ombre e scrutando dentro di sé, con la calda partecipazione del narratore e l’imparziale sguardo del saggista, Covacich si lascia sedurre dal richiamo del labirinto Trieste. Gli eventi e gli aneddoti in esso contenuti sono l’espressione del bisogno di fare e conti con la storia di chi lo ha preceduto (il padre, la madre, i nonni). E percorrere le loro storie e quelli degli scrittori permette a Covacich di liberarsi di quel groviglio di memorie, di dolori che la terra di confine porta con sé.
Certo è che lo scrittore triestino si allontana dalle ‘storie di vite prese e schiacciate dal malessere della propria esistenza’, che abbondano nei suoi romanzi. Senza per questo dimenticare la sua perizia di narratore e la sua capacità di far diventare un aneddoto un vero e proprio racconto.
Sta di fatto che La città interiore raccoglie cosa significhi ‘essere triestini’ e il ‘come esserlo’ attraverso anche le storie di italiani sbagliati (quegli uomini e di quelle donne che a Trieste sono nate e che ad essa sono state legate per tutta l’esistenza) «per i quali talvolta l’uso del dialetto – anche ai livelli elevati di uno Svevo o addirittura di Joyce – diventa il simbolo di una appartenenza altrimenti difficile da far capire a chi vive in un suo oscuro microcosmo provinciale».
Da, infatti, sempre il capoluogo friulano è stato il luogo di tolleranza e di incontri letterari, come lo stesso Covacich racconta. La città sonnacchiosa e di provincia di Umberto Saba, di Italo Svevo, di James Joyce, ma anche di Pier Antonio Quarantotti Gambini, di Bobi Bazlen, di Eugenio Montale e della psicanalisi. È la città raccontata in quel favoloso libro di Giorgio Voghera, intitolato Gli anni della psicanalisi, ma anche quella della tragedia personale di Sergio Ferrero, descritta di Emilio Jona.
A Trieste di Jan Morris, autrice molto nota nel mondo anglosassone per i suoi libri di viaggio, «arriva a Trieste con il primo contingente inglese nei panni di James Morris, uomo» coglierà la natura del confronto sloveni/italiani. Trieste sarà il luogo di nascita di Antonio Bibalo, compositore istriano, che ha rivoluzionato la musica scandinava. Il musicista, infatti nell’estate del ‘47 lascerà la stanzetta nella casa della madre in cui vive con la moglie per arrivare in stazione e comprare un biglietto del treno direzione Ventimiglia, prima tappa di una peregrinazione che lo porterà a diventare il più importante musicista del Novecento norvegese restando del tutto ignoto in Italia. Anche Pino Robusti, morto nella Risiera di San Sabba di cui resta la struggente lettera alla fidanzata, o il poeta e partigiano croato Ivan Goran Kovacic ucciso dai cetnici nel 1942 saranno figure che passeranno o vivranno nella città di confine.
Per Goran Kovacic, Mauro Covacich ha un interesse particolare: all’inizio è tutto in quella K del cognome. Alla ricerca della sua tomba, il cui luogo è rimasto sconosciuto, Covacich dedica un febbrile pellegrinaggio-reportage durante il quale fa una tappa anche nella Materada di Fulvio Tomizza. Il pellegrinaggio così come la lettura di Quarantotti Gambini gli permettono di comprendere chi è. «Appartenendo a questa Trieste capisco perché su di me L’onda dell’incrociatore, scritto peraltro da un aristocratico come Quarantotti Gambini, abbia esercitato subito un effetto liberatorio: Ario e i suoi compari, che abitano sui ponteggi traballanti dei circoli di canottaggio e ardevano una vita tutta fisica […] ed erano la mia gente. Mentre La coscienza di Zeno mi poneva di fronte al triestino non ero e non sarei mai stato», scrive ad un certo punto.
Trieste è anche la città, ammaliata dalle parole di Benito Mussolini, in cui che si commette un gesto di odio nei confronti della comunità slovena: dar fuoco alla casa della cultura slovena. E a cui è imposto a tutti di parlare italiano, come racconta Covacich ricordando il grande scrittore Boris Pahor, le cui opere, da qualche anno tradotte in italiano, hanno suscitato un certo interesse, e hanno permesso di raccontare un momento poco chiaro ai più, quello delle limitazioni alla comunità slovena di Trieste.
Trieste è il capoluogo friulano e il luogo in cui migliaia di persone sono morte concentrate dai nazisti nella Risiera di San Saba, dove finisce anche uno scrittore come Stuparich. Il luogo dove a pochi chilometri si trova la foiba di Basovizza.
È difficile dire, se questo libro sia ‘uno specimen di lavori in corso’, e preluda ad una saga familiare che permetterà al suo autore di illustrare la storia di Trieste degli anni ottanta e novanta, o se si concluda qui, quello che è certo è che questo libro, insieme al recente Istantanee di Claudio Magris e I mari di Trieste, libro a cura di Federica Mazon, permettono di comprendere sempre di più una parte della letteratura italiana, che fino ad ora rimasta limitata nella dimensione regionale.
È anche vero che Covacich svolge con caparbia rettitudine il suo compito di testimone, della memoria ma anche di un’attualità esausta e frammentata, perché il racconto non può essere solo cronaca, ammiccamento, quanto piuttosto il filtro di suggestioni collettive stemperate da una generosa forma di autoanalisi che passa attraverso tutte le colpe e le assenze della nostra epoca confusa.
Dalla presentazione dell’editore:
È il 4 aprile 1945. Quel bambino sta trasportando una sedia tra le macerie della città liberata dai nazifascisti ed è diretto al comando alleato, dove lo attende suo padre – dal cognome vagamente sospetto, Covacich – sottoposto i un interrogatorio. E quella sedia potrebbe scagionarlo. Sempre Trieste, 5 agosto 1972. I terroristi di Settembre Vero hanno fatto saltare due cisterne di petrolio. Un bambino, Vlauro Covacich, tra le gambe di suo padre (il bambino che trascinava la sedia ventisette anni prima nella Trieste liberata), contemplando le colonne di fumo dalle alture carsiche sopra la città, chiede: “Papà, sento in guera?” Mauro Covacich torna nella sua Trieste, con un libro dal ritmo incalzante, avventuroso romanzo della propria formazione, scritto con la precisione chirurgica di un analista di guerra e animato dalla curiosità di un reporter. “La città interiore” è la cartografia del cuore di uno scrittore inguaribilmente triestino; è il compiuto labirinto di una città, di un uomo, della Storia, che il lettore percorre con lo stesso senso di inquieta meraviglia che accompagnava quel bambino del 1945 e quello del 1972; un labirinto di deviazioni e ritorni inaspettati, da cui si esce con il desiderio di rientrarci.